C’è un’etica, quasi un DNA culturale, che ha definito la Germania del Dopoguerra: quella della Schwäbische Hausfrau, la casalinga sveva. Un archetipo di prudenza, avversione al debito e meticolosa gestione del bilancio familiare. Questo principio, elevato a virtù nazionale, è stato il pilastro su cui la Germania ha costruito il suo miracolo economico, la sua stabilità, la sua reputazione di motore d’Europa. Per decenni, ha funzionato in modo impeccabile.
Ora, però, un’ombra si allunga su questo dogma. Il motore tedesco, un tempo inarrestabile, non solo perde colpi, ma si trova nel mezzo di quella che un grande economista come Heiner Flassbeck definisce senza mezzi termini “la più lunga recessione di sempre dal Dopoguerra”. La domanda che emerge, tanto scomoda quanto inevitabile, scuote le fondamenta delle nostre certezze: e se la più grande virtù tedesca fosse diventata la loro condanna? Se la malattia che li affligge non fosse un virus esterno, ma un’autointossicazione nata dalla loro stessa, celebrata ossessione per il risparmio?
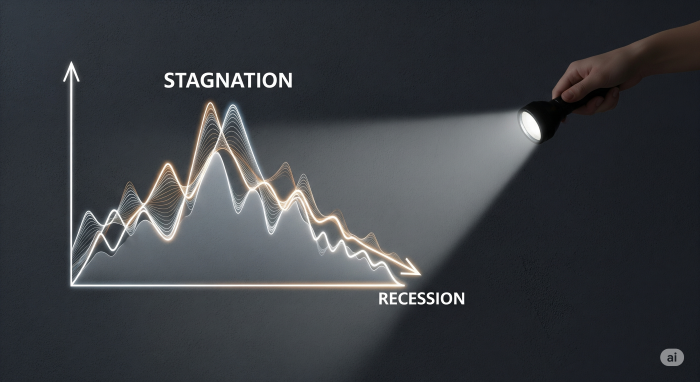
Perché la Germania è in Recessione? Oltre le Statistiche, una Crisi di Identità
Quando si parla di stagnazione tedesca, non si tratta solo di un punto percentuale di PIL in meno. Si tratta di un sentimento diffuso, di un’incertezza che serpeggia dai consigli di amministrazione delle multinazionali di Stoccarda fino ai tavoli dei bar di Berlino. È la sensazione che il modello che ha resto la Germania grande si stia sgretolando. Le commesse per l’industria calano da anni, un declino inesorabile che i telegiornali raccontano con grafici preoccupanti ma che le famiglie vivono come ansia per il futuro.
Online, il dibattito è acceso. C’è chi racconta storie di piccole imprese schiacciate da regolamenti incomprensibili, chi lamenta l’impossibilità di trovare lavoratori qualificati, chi si sfoga contro una classe politica percepita come distante e incapace di offrire una visione. Ma secondo la diagnosi spietata di Heiner Flassbeck, questi sono solo i sintomi. La malattia è più profonda e ha un nome preciso: un deficit cronico di domanda, una voragine creata dalle classi dirigenti tedesche, nel cuore dell’Europa. In poche parole, sono in crisi perché i tedeschi hanno smesso di desiderare, di spendere, di investire. E la ragione è legata a un peccato originale che hanno commesso all’alba dell’Unione Monetaria.

Il Paradosso dell’Euro: Come la “Forza Buona” della Germania ha Danneggiato i Vicini
Ricordate gli anni Duemila? L’euforia per la nuova moneta e le famose riforme Schröder, celebrate come il toccasana che ha reso la Germania di nuovo competitiva. In un’intervista memorabile, Flassbeck smonta questo mito pezzo per pezzo. Quelle riforme, ci spiega, hanno funzionato solo perché abbiamo “abusato” dell’euro. Abbiamo messo in atto un gigantesco dumping salariale: mentre la produttività delle nostre fabbriche cresceva, i nostri salari sono rimasti al palo, racconta Flassbeck.
Immaginate due corridori che partecipano a una gara a coppie, legati per una caviglia. Uno dei due, la Germania, decide di correre trattenendo il fiato, con uno sforzo immane ma efficace, per guadagnare terreno. L’altro corridore, diciamo la Francia o l’Italia, continua a respirare normalmente, come da accordi. Il risultato? La coppia avanza, ma solo perché il secondo corridore è costretto a uno sforzo innaturale per stare al passo del primo, finendo per perdere l’equilibrio e accumulare un “debito” di ossigeno. Questo è ciò che è accaduto in Europa. La Germania ha accumulato enormi surplus commerciali, vendendo al mondo molto più di quanto comprasse, mentre i nostri partner erano costretti a indebitarsi per acquistare i nostri prodotti e tenere in vita le loro economie, sempre secondo Flassbeck.
Si sono autoproclamati “la forza buona” d’Europa, ma, come un vicino di casa troppo zelante che pota gli alberi del giardino altrui fino a farli seccare, hanno creato uno squilibrio devastante. E oggi, quel vicino indebitato e sfiancato non può più permettersi di comprare i i beni tedeschi. La loro vittoria di ieri è la causa della loro crisi di oggi.

Il Vero Problema non è il Debito, ma il Risparmio: la Teoria della “Casalinga Sveva” al Banco degli Imputati
Eccoci al cuore del problema, al tabù più grande della cultura tedesca: il risparmio. Siamo cresciuti con il mito della Schwäbische Hausfrau, la casalinga sveva, simbolo di prudenza, parsimonia e avversione al debito. Un’etica impeccabile per una famiglia, ma un veleno mortale per un’intera nazione. Flassbeck ci sbatte in faccia una verità matematica ineluttabile: ogni euro risparmiato da un lato deve essere un euro di debito dall’altro. Non si scappa.
I dati della Bundesbank sono impressionanti: in un solo anno, le famiglie tedesche hanno messo da parte 300 miliardi di euro. A questi si aggiungono i risparmi delle imprese. Si è creata una voragine di quasi 350 miliardi di euro. Questi sono soldi che sono stati guadagnati, ma non sono stati spesi. Sono domanda che è svanita nel nulla. Chi la colma? In un’economia sana, dovrebbero essere le imprese a prendere in prestito quei soldi per investire in nuovi macchinari, nuove tecnologie, nuovi posti di lavoro. Ma le nostre imprese, prudenti fino all’eccesso, non lo fanno.
Resta solo lo Stato. O l’estero. Per vent’anni, abbiamo “esportato” i nostri risparmi, costringendo il resto del mondo a indebitarsi con noi, sostiene Flassbeck. Ora che il mondo frena, quella voragine si apre sotto i nostri piedi. Continuare a predicare l’austerità, tagliare la spesa pubblica, ridurre il Bürgergeld, come suggerisce gran parte della classe politica, è come cercare di curare un anemico con i salassi. È una follia economica che non fa altro che allargare la voragine della domanda, spingendo il paese sempre più a fondo nella recessione. Qual è il senso di chiedere sacrifici a chi già non spende, se il risultato è solo un ulteriore crollo dei consumi e, di conseguenza, dei profitti delle nostre stesse aziende?

Lo Specchio Americano: Perché gli USA Crescono e l’Europa Resta Indietro?
Mentre noi siamo avviluppati nelle nostre discussioni dogmatiche sul pareggio di bilancio, dall’altra parte dell’Atlantico, gli Stati Uniti crescono a un ritmo che noi possiamo solo sognare, si chiede Flassbeck. Ma perché? La risposta, secondo Flassbeck, è dolorosamente semplice: gli americani hanno capito che lo Stato deve intervenire. Sia l’amministrazione Trump con i suoi tagli fiscali, sia quella Biden con i suoi massicci piani di investimento, hanno usato la leva del debito pubblico per iniettare domanda nell’economia.
Non si tratta di ideologia, ma di puro pragmatismo. Hanno capito che in un momento di debolezza del settore privato, lo Stato deve agire come “investitore di ultima istanza”. Inoltre, la loro banca centrale, la Federal Reserve, ha un doppio mandato: non solo la stabilità dei prezzi, ma anche la massima occupazione. La Banca Centrale Europea, invece, è ossessionata solo dall’inflazione, anche quando questa non è più un problema.
Guardare all’America è come guardarsi in uno specchio deformante che ci mostra la rigidità tedesco, secondo Flassbeck. Loro agiscono, noi discutiamo. Loro investono, noi risparmiamo. Loro crescono, noi arranchiamo. Siamo così convinti che la nostra sia l’unica via moralmente giusta, quella della frugalità e del rigore, che non ci accorgiamo che ci sta portando dritti verso il declino. È possibile che un intero continente sia prigioniero di un’idea tanto nobile quanto economicamente suicida?

Una Soluzione Radicale: Più Debito per Uscire dalla Crisi?
Se la diagnosi è un crollo della domanda, la cura non può che essere uno shock di domanda. La proposta di Flassbeck è tanto semplice quanto eretica per le orecchie tedesche: lo Stato deve indebitarsi, e non di poco. Non per finanziare progetti inutili, ma per orchestrare la più grande riduzione di tasse e contributi della nostra storia. L’obiettivo è mettere più soldi nelle tasche dei cittadini e delle imprese, subito.
L’idea è che, con più liquidità a disposizione, le persone torneranno a consumare e le aziende, vedendo i loro ordini finalmente risalire, ritroveranno la fiducia per investire. Lo Stato agirebbe come una sorta di defibrillatore per un cuore che ha smesso di battere. Certo, il debito pubblico aumenterebbe, ma in un’economia che ricomincia a crescere, quel debito diventerebbe sostenibile. È un rischio? Forse. Ma è certamente meno rischioso che restare fermi a guardare il motore che si spegne del tutto. Dobbiamo superare questa barriera psicologica, questo terrore quasi infantile del debito, e capire che, in determinate circostanze, è l’unico strumento che abbiamo per salvarci.

Un Vuoto Intellettuale al Vertice: Quando la Politica Ignora l’Economia
Forse il punto più amaro dell’analisi di Flassbeck riguarda la classe dirigente. La sua critica è feroce: politici di ogni schieramento sembrano intrappolati in un paradigma economico vecchio di cinquant’anni, incapaci di comprendere la natura del problema. Si circondano di consulenti che ripetono le stesse stanche litanie su “competitività” e “riforme strutturali”, ignorando la semplice, brutale realtà dei numeri.
Cosa succede quando chi è al timone non solo non conosce la rotta, ma non sa nemmeno leggere una mappa? Il rischio è di navigare a vista, andando a sbattere contro scogli che un buon economista vedrebbe a miglia di distanza. Manca una visione, manca il coraggio di spiegare al paese verità scomode, manca la capacità di articolare un discorso che vada oltre lo slogan del “dobbiamo stringere la cinghia”. Questo vuoto intellettuale è forse più pericoloso della crisi stessa, perché ci impedisce di trovare una via d’uscita.

Oltre la Crisi: Quale Futuro per la Germania e l’Europa?
La crisi economica della Germania non è un problema solo tedesco. È il problema di un’Europa che ha costruito la sua casa su fondamenta squilibrate. La diagnosi di Heiner Flassbeck è un pugno nello stomaco, ma è anche un disperato appello alla ragione. Costringe la Germania a guardare in faccia le proprie contraddizioni e a porsi domande fondamentali.
Forse, la via d’uscita da questa lunga notte non passa per nuovi sacrifici, ma per un nuovo modo di pensare. Un pensiero coraggioso, controintuitivo e, in fin dei conti, più responsabile. La discussione è aperta, e il futuro dipende dalle risposte che sapremo darci.

