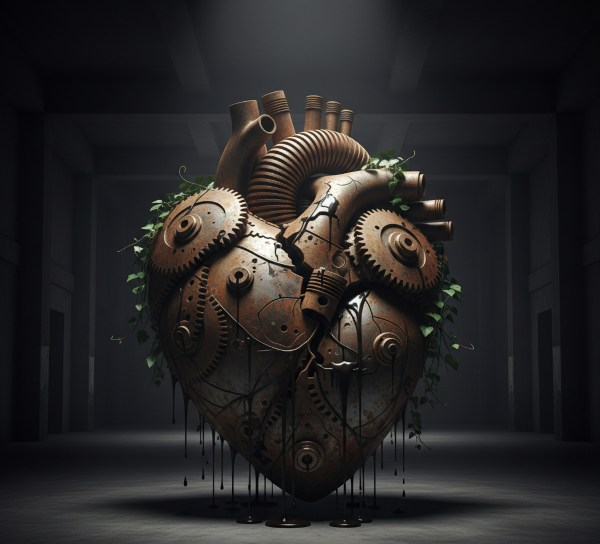C’è un silenzio che sta calando su alcune valli industriali d’Europa. È il silenzio che segue l’ultimo turno di lavoro, il silenzio di un capannone vuoto dove fino a ieri risuonava il ritmo delle macchine. Per decenni, abbiamo guardato alla Germania come al motore instancabile del continente, un modello di efficienza, qualità e prosperità. Il “Made in Germany” non era solo un’etichetta, ma una promessa di eccellenza. Oggi, quella promessa scricchiola. Notizie di giganti come Bosch che tagliano migliaia di posti di lavoro non sono più incidenti di percorso, ma sintomi di una condizione più profonda, una febbre che non accenna a scendere.
Cosa succede quando il cuore manifatturiero d’Europa inizia a mostrare segni di affaticamento? È una semplice recessione o l’inizio di un’era completamente nuova e molto più incerta? In una recente, esplosiva intervista pubblicata su YouTube, il grande economista tedesco Hans-Werner Sinn ha offerto una diagnosi tanto brutale quanto lucida: la Germania è nel mezzo di un processo di deindustrializzazione autoindotta, un lento suicidio economico mascherato da buone intenzioni. La sua analisi non è solo un resoconto della crisi tedesca, ma uno specchio in cui l’Italia e l’intera Europa dovrebbero guardare con estrema attenzione.

2018: L’Anno in Cui la Musica si è Fermata per l’Industria Tedesca
Ogni grande cambiamento ha un punto di origine, un momento in cui le curve statistiche smettono di salire e iniziano una lenta, inesorabile discesa. Secondo Sinn, per la Germania industriale quel momento è stato il 2018. Da allora, il declino è diventato misurabile, tangibile. Non si tratta di una fluttuazione ciclica, ma di una frattura strutturale. I dati sono spietati: la produzione industriale complessiva è crollata di circa il 15%. Ma è scavando nei settori che hanno reso grande la Germania che si percepisce la vera magnitudine del problema. L’industria automobilistica e quella chimica, i due pilastri del tempio economico tedesco, hanno subito una contrazione del 22%.
Questa non è solo statistica. È la storia di un’azienda chimica che, invece di espandere il suo sito storico sul Reno, decide di costruire il suo nuovo, enorme impianto in Cina. È la storia di un fornitore automobilistico, un tempo fiore all’occhiello dell’innovazione, che ora deve annunciare tagli dolorosi perché il mondo per cui produceva non esiste quasi più. Questi non sono fallimenti aziendali, ma le conseguenze logiche di un ambiente diventato ostile alla produzione. La diagnosi di Sinn è netta: la Germania è diventata “herzkrank”, malata di cuore, e la malattia colpisce proprio il suo muscolo più forte, l’industria.

Il Miracolo Verde Svanito: Quando l’Ideologia Incontra il Muro della Realtà
Come è stato possibile arrivare a questo punto? Fino a poco tempo fa, la narrativa politica, incarnata dalle promesse dell’ex cancelliere Olaf Scholz, parlava di un imminente “miracolo economico verde”. Si evocavano tassi di crescita degni degli anni ’50 e ’60, un futuro radioso in cui la Germania, pioniera della transizione ecologica, avrebbe guidato il mondo sviluppando e vendendo le tecnologie del domani. Due piccioni con una fava: salvare il pianeta e rafforzare l’economia.
Secondo Hans-Werner Sinn, questa visione era “un’assurdità totale fin dall’inizio”. La sua critica è feroce: alla popolazione è stato venduto un sogno, la favola che la transizione energetica non solo non sarebbe costata nulla, ma avrebbe generato enormi vantaggi competitivi. Si è parlato di “sole che non manda fatture”, dimenticando di menzionare i costi esorbitanti per le infrastrutture, lo stoccaggio e la stabilità della rete. La realtà, sostiene Sinn, è che è stata nascosta la natura stessa del compromesso economico: per ottenere un obiettivo (ambientale), bisogna essere disposti a sacrificare qualcosa su un altro fronte (economico). Affermare che non ci sarebbero state rinunce, ma solo vantaggi, è stato, a suo dire, “profondamente disonesto”. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: invece del miracolo, è arrivata la recessione, e i prezzi dell’energia in Germania sono tra i più alti del mondo industrializzato, un veleno per qualsiasi industria energivora.

L’Automobile, Cuore Infranto della Germania: Una ‘Truffa’ Made in Brussels?
Nessun settore incarna la crisi tedesca meglio dell’automotive. Per decenni, l’auto tedesca è stata un’icona globale. Oggi, la sua produzione è in caduta libera. La causa, secondo Sinn, non è una mancanza di domanda, ma una serie di decisioni politiche, in particolare le normative europee sulle emissioni delle flotte. Qui l’analisi si fa tecnica ma illuminante. L’UE ha imposto limiti di CO2 per i veicoli nuovi così stringenti da essere tecnicamente irraggiungibili per un motore a combustione tradizionale. L’obiettivo, nemmeno troppo velato, era forzare il passaggio all’elettrico.
Il problema, che Sinn definisce senza mezzi termini una “Mogelei” (una truffa, un imbroglio), risiede nel calcolo. Le auto elettriche vengono conteggiate a “zero emissioni” allo scarico. Questo, ovviamente, ignora completamente il CO2 emesso per produrre l’elettricità che le alimenta, che in gran parte d’Europa proviene ancora da centrali a gas, carbone o altre fonti fossili. È un’operazione contabile che pulisce la coscienza sulla carta, ma che non risolve il problema a livello di sistema, mentre demolisce un intero settore industriale basato su una tecnologia perfezionata in un secolo. Questa politica, influenzata secondo Sinn da precisi interessi industriali francesi, ha di fatto messo fuori legge il prodotto di punta dell’industria tedesca, costringendola a una riconversione forzata e costosissima in un campo, quello delle batterie e del software, dove altri partivano con un enorme vantaggio.

Il Paradosso Climatico: Perché i Sacrifici della Germania Potrebbero Non Salvare il Pianeta
E se tutto questo dolore economico non servisse nemmeno a salvare il clima? È questa la domanda più provocatoria e inquietante posta da Sinn. Il suo ragionamento si basa su una semplice logica di mercato globale. I combustibili fossili come petrolio e carbone sono materie prime scambiate su un mercato mondiale. Se un grande acquirente come la Germania decide di ridurne drasticamente il consumo, non fa sparire quei combustibili. Semplicemente, ne fa calare il prezzo.
Immaginate un grande mercato. Se uno dei clienti più ricchi smette di comprare le mele, il venditore non le butta via: le offre a un prezzo più basso agli altri clienti. Allo stesso modo, il petrolio non comprato dall’Europa viene acquistato a prezzi più convenienti da paesi con una fame insaziabile di energia, come la Cina o l’India, che continuano a bruciarlo. L’effetto netto sul CO2 globale, conclude amaramente Sinn, è vicino allo zero. L’unico risultato concreto è lo spostamento delle emissioni e, con esse, delle industrie, da un angolo del pianeta a un altro. L’unica azione unilaterale davvero efficace, sostiene, sarebbe lasciare nel sottosuolo le risorse che si possiedono (come la lignite tedesca) o investire massicciamente in tecnologie di cattura del carbonio (CCS). Ma la discussione pubblica, osserva, ignora quasi completamente questa logica elementare.

Stretti in una Morsa: La Tenaglia Geopolitica che Soffoca il ‘Made in Germany’
Come se non bastasse, il declino industriale tedesco è accelerato da una pressione geopolitica che assomiglia a una tenaglia. Da un lato, l’Unione Europea, con le sue regolamentazioni, sta rendendo sempre più difficile e costoso produrre in Germania. Dall’altro lato, gli Stati Uniti, con politiche aggressive come l’Inflation Reduction Act, stanno srotolando il tappeto rosso alle aziende tedesche, offrendo sussidi, energia a basso costo e un ambiente normativo più favorevole.
L’invito dell’ex presidente Trump alle case automobilistiche tedesche è emblematico: “Venite a produrre le vostre auto in America”. La beffa finale? Grazie agli accordi commerciali, quelle stesse auto prodotte negli USA potrebbero poi essere rivendute in Europa senza dazi. In pratica, la Germania viene spinta a smantellare le sue fabbriche da una combinazione di regole interne punitive e incentivi esterni allettanti. Non si tratta più di una competizione leale, ma di una lotta per la sopravvivenza in cui le aziende sono costrette a scegliere la via della delocalizzazione per non soccombere.

Il Futuro Visto dai Nipoti: Dalla ‘Work-Life Balance’ alla ‘Minimizzazione dei Danni’
Quale futuro attende le prossime generazioni in un paese che sembra aver smarrito la sua vocazione industriale? La visione di Sinn è priva di illusioni. Per i suoi nipoti, e per tutti i giovani europei, la sfida non sarà più gestire la crescita, ma contenere il declino. L’espressione che usa è gelida: “Schadensminimierung”, minimizzazione dei danni. Si aggiunge a questo la bomba a orologeria demografica: la generazione dei baby boomer sta andando in pensione, lasciando un vuoto enorme nel mercato del lavoro e un peso insostenibile sui sistemi pensionistici.
In questo scenario, concetti oggi di moda come la “work-life balance” potrebbero apparire come un lusso di un’epoca passata. La realtà potrebbe imporre un ritorno a un’etica del lavoro più dura, non per scelta, ma per necessità. L’era della prosperità crescente, data per scontata da intere generazioni del dopoguerra, potrebbe essere finita. Il compito che ci attende, suggerisce Sinn, non è sognare futuri gloriosi, ma costruire un percorso realistico per navigare in acque molto più agitate, basato su un’analisi onesta dei costi e dei benefici.

Oltre la Germania: Quali Lezioni per l’Italia e il Futuro dell’Industria Europea?
L’analisi di Hans-Werner Sinn è un pugno nello stomaco. Potremmo essere tentati di liquidarla come eccessivamente pessimistica o di considerarla un problema esclusivamente tedesco. Sarebbe un errore gravissimo. La Germania è il canarino nella miniera dell’industria europea. Le forze che la stanno mettendo in ginocchio – costi energetici fuori controllo, regolamentazioni ideologiche, concorrenza globale spietata e un dibattito pubblico che spesso preferisce le favole alla realtà – sono le stesse che minacciano il tessuto manifatturiero italiano e di molti altri paesi europei.
La sua critica ci costringe a porci domande fondamentali. Stiamo basando le nostre politiche industriali ed energetiche su analisi realistiche o su narrazioni ideologiche? Siamo consapevoli dei compromessi che ogni scelta comporta? E, soprattutto, siamo disposti a pagare il prezzo di una transizione che, se gestita male, rischia di distruggere la nostra base di prosperità?
Forse la lezione più importante dell’onestà brutale di Sinn è questa: non esiste una terza via magica. Ignorare la realtà non la fa scomparire. O l’Europa trova un modo per conciliare la sostenibilità ambientale con la competitività industriale, oppure rischia di diventare un continente bellissimo, pulito e irrilevante. Un museo a cielo aperto, finanziato dai turisti che verranno ad ammirare le rovine della nostra passata grandezza industriale. La domanda che rimane aperta è: siamo ancora in tempo per cambiare rotta?